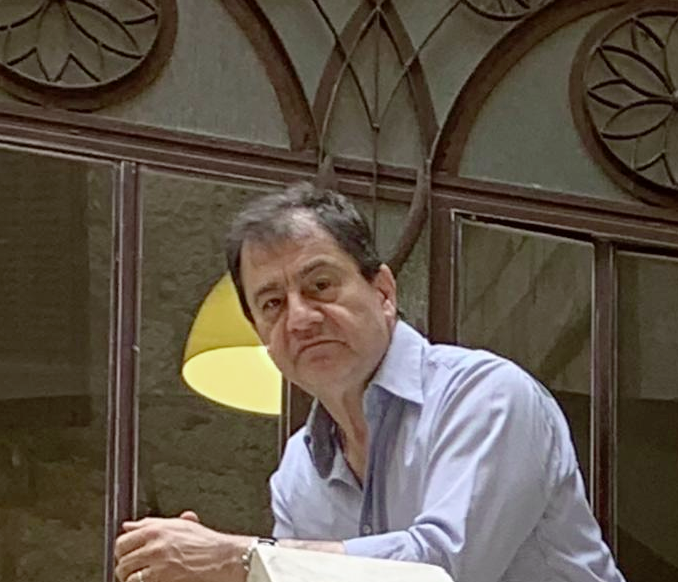Mi piace iniziare da una delle storie più cruente della mitologia greca partendo da una trilogia di Eschilo. E’ la storia del contrasto tra due fratelli che si odiano, che si contendono il trono di Micene. Ma la loro è anche una lotta resa più aspra dal fatto che uno dei due ha una relazione con la moglie dell’altro e quindi quest’ultimo escogita una vendetta ai danni del primo fratello. E’ quella di Atreo, Tieste, dei figli Egisto, Agamennone, di Oreste e della morte di Clitennestra, con l’intervento divino a regolare la giustizia. Storia di sangue e vendette. Eschilo individua in questa vicenda un passaggio storico: il passaggio da un mondo primitivo, dominato dalla violenza al mondo civilizzato della polis, della città stato di Atene. E’ il passaggio dalla legge del taglione al tribunale: è il passaggio dalla vendetta alla giustizia, dalla barbarie alla civiltà.
Questo impatto emotivo serve per una riflessione. In buona sostanza il diritto penale moderno, quello delle nostre società civilizzate, dovrebbe essere il risultato del superamento definitivo della logica della vendetta. Ma vorrei proporvi due interrogativi connessi tra loro. Il primo è questo: siamo sicuri che attraverso l’immaginario delle tragedie di Eschilo ciò che viene descritto sia un passaggio lineare e irreversibile da una società di vendetta a una di giustizia? E il secondo è: il diritto penale moderno, come è noto, si fonda sul concetto di pena. Possiamo dire che la nozione di pena sia tale da non portare alcuna traccia del precedente concetto di vendetta? Per rispondere a questi interrogativi ricorriamo a due filosofi lontani nel tempo e diversi tra loro. Il primo è Nietzsche e mi riferisco al suo testo che si intitola Genealogia della morale. Nietzsche si interroga esattamente sul problema che ci siamo posti ora. Si domanda, cioè, quale sia l’origine della nozione di pena, da dove tragga origine, attraverso quale percorso storico concettuale si sia affermata. Secondo Nietzsche l’origine va collocata nel rapporto contrattuale tra creditore e debitore, il più antico rapporto economico che si conosca. Ma affinché il debitore si senta affettivamente vincolato alla restituzione e affinché il creditore gli creda è indispensabile, sottolinea Nietzsche, che il creditore ottenga dal debitore qualcosa in pegno. E che cosa può dare il debitore in pegno? Può offrire il proprio corpo o la propria donna, o la propria libertà, o la propria vita.
Il debitore insolvente si collocherebbe, quindi, al di fuori di una relazione equilibrata. Rompe l’equilibrio e per ripristinarlo gli si infligge una pena, una sofferenza che possa dare soddisfazione al creditore. C’è una seconda chiave di lettura, quella di un filosofo del Novecento, Paul Richer. Si parte da una precisazione di carattere etimologico: il termine pena viene dal greco “poinè”, la cui radice ritroviamo anche nel verbo latino punire. In latino punire vuol dire purgare, purificare. Potremmo aggiungere lavare in maniera da togliere una macchia. La pena, allora, sarebbe una azione che serve per lavare una situazione precedente, e Richer ci aiuta a capire questo passaggio quando dice che da questo punto di vista il termine “pena” assomiglia molto ad un altro il cui significato è più immediato e più trasparente: castigo.
Qui il significato è più immediato perché il termine deriva dal latino “castus” che vuol dire puro pulito, non contaminato. Si ipotizza che ci sia una condizione originale integra, che è stata macchiata da una colpa. Allora il concetto di pena, in tutta evidenza, si fonda su due presupposti. Il primo è una visione complessiva della realtà, in cui in origine c’è un universo bene ordinato, ben costituito, integro e che viene vulnerato, cambiato, deformato quando si incorre in una colpa. Il secondo è che la pena corrisponda ad una condotta di annullamento che cancella la colpa. Per concludere cito le parole della maggiore filosofa del Novecento, Simone Weil, che scrive: “…il diritto, in maniera particolare il diritto penale, non è un’altra dimensione della giustizia, non è la sua immagine sbiadita, ma è il suo avversario irriducibile”. E aggiunge il filosofo antropologo, Renè Girard, ciò che emerge alla radice del diritto di pena è la persistenza implacabile del meccanismo della vendetta. Un tentativo ricorrente, ma fallito, di razionalizzare la vendetta. La pena, scriveva Girard, è violenza senza rischio di vendetta. Siccome dal punto di vista teorico non è possibile trovare altra giustificazione al concetto di pena che non sia l’esigenza che la società avverte di una vendetta nei confronti del reo, l’unica cosa possibile, forse, è affidarsi, dove è possibile, al buon senso. Queste nozioni sono alla base del diritto penale, del riconoscimento dell’insuperabilità di questa aporia, senza dimenticare – come già Pindaro e poi Platone scrivevano – che la “tyche”, ovvero la giustizia, abita presso Dio. Ma se è vero che gli uomini possono creare solo un diritto imperfetto, lacunoso e difettivo, che porta con sé un carico insuperabile di contraddizioni, è pur vero che solo quando la pena non diventi retributiva può aspirare al recupero della persona umana.