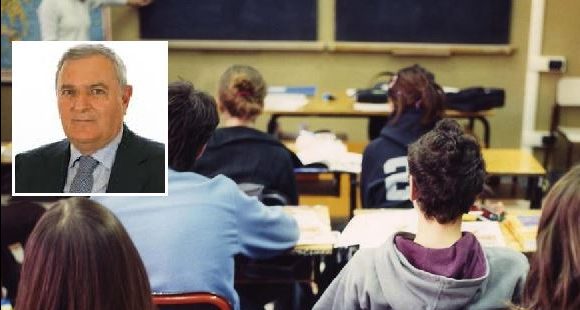Dalla fondazione del Regno d’Italia ad oggi, le riforme della scuola sono state adottate con cadenza ciclica ed assommano ad una ventina circa. Tutte, però, hanno ricevuto in dote la stessa sorte: quella di essere modificate, se non cancellate, dai ministri della Pubblica Istruzione che si sono succeduti nel corso degli anni. Insomma: un’orgia di buone intenzioni, congetture, ragionamenti pedagogici e filosofici che, purtroppo, si sono via via trasformati, all’atto pratico, in un lento decadimento della qualità e della quantità dei saperi. Questa sorta di iper riformismo si è accentuata ulteriormente negli ultimi decenni a partire dall’istituzione della scuola dell’obbligo fino ai giorni nostri. Infatti la cosiddetta legge sulla “Buona Scuola” è già in gran parte falcidiata da successivi emendamenti, direttive e circolari ministeriali che ne hanno svuotato il senso e gli obiettivi. In soldoni, di questi tempi, è ritornata ad essere vincente l’idea “sessantottina” che la scuola debba essere il luogo dell’accoglienza e della parificazione sociale e non il luogo dell’istruzione e dell’educazione. Che, in poche parole, il compito di ridurre il disagio sociale valga più, come missione civica, che insegnare ai ragazzi a leggere e scrivere e prepararsi alla vita. Concetti, questi ultimi, che sono risultati graditi sia a coloro i quali nella scuola vedono uno dei tanti ammortizzatori sociali resi disponibili dalla gestione statale, sia dagli utenti della scuola, quegli stessi genitori e studenti, che da una scuola declassificata, massificata e di manica larga nei giudizi, pensano di trarre il vantaggio di acquisire il cosiddetto “pezzo di carta” senza che, però, questo sia accompagnato da un effettiva preparazione.
E’ stata proprio questa diffusa, quanto distorta mentalità utilitaristica, costruita nel corso degli anni, dell’acquisizione, comunque sia, di un “titolo di studio, a portare, successivamente, molti giovani ad accampare la pretesa che lo Stato dovesse poi provvedere alla loro collocazione nel mondo del lavoro. Ovverossia che lo Stato dovesse anche preoccuparsi, dopo averli malamente istruiti e facilmente minuti del titolo di studio, di collocarli utilmente nel tessuto sociale e produttivo.
Sono stato tra i parlamentari che hanno convintamente votato la cosiddetta “Buona Scuola” per il semplice fatto che essa si proponeva l’ambizioso progetto di riportare, all’interno della scuola, valori ormai desueti come la meritocrazia, la capacità, la verifica dei saperi (sia nei docenti, sia nei discenti), nonché un regime di regole che facesse giustizia delle furbizie, delle comodità e delle deviazioni ideologiche che si erano cristallizzate nel corso degli anni. Una specie di patto scellerato stipulato (e mai scritto) tra coloro che sceglievano la comodità e lo stipendio garantito, e coloro che richiedevano ai propri figli percorsi semplificati ed agevolati per raggiungere l’agognata meta. Purtroppo quel “patto scellerato” non è stato toccato. E la riforma, modificata e stravolta, è rimasta nel classico novero delle cosiddette “buone intenzioni”.
Diciamocela tutta: una scuola nella quale per 8 milioni di studenti opera circa un milione di addetti ai lavori, rappresenta una caterva di voti che le forze politiche non hanno mai voluto trascurare. Una così grande realtà si è trovata così “mollata” nelle mani di coloro i quali sapevano dove metterle, a tutto vantaggio della qualità dell’istruzione. E’ l’eterna storia dei servizi pubblici gestiti in regime di monopolio dallo Stato, ove l’ingerenza della politica e quella del sindacato, determinano il naufragio di ogni criterio di ammodernamento e di efficientamento ed, in generale, di una vera autonomia rispetto agli interessi politici, elettorali e sindacali che si agitano sotto traccia.
Fino a quando non diremo con grande schiettezza queste cose ciascuno tenderà di imporre la propria verità che coincide con il voler addossare agli altri la responsabilità di ciò che non funziona facendo ovviamente salvi i propri interessi. È facile blandire la “massa” degli addetti alla scuola come leva che procuri consenso elettorale o per chiedere (ed ottenere) agevolazioni che con lo scopo e la missione di migliorare la scuola non hanno nulla a che vedere.
Una scuola burocratizzata che applichi il principio dell’uguaglianza, ovvero del “tutti somari”, trasformando i docenti in assistenti sociali e la scuola stessa in uno strumento di parificazione tra le classi e non di istruzione per tutti i ceti sociali, non può andar bene. Semplicemente non va. Per salvare la scuola occorre, all’opposto, che si abbandoni da una parte l’idea di comodità e di stipendi assicurati e dall’altra l’idea che lo Stato possa distribuire pezzi di carta che qualcuno ancora continua a chiamare, eufemisticamente, “titolo di studio” ma che, in realtà, così fatti, non servono a niente.